Nata a Roma ma trasferitasi ben presto negli Stati Uniti, Ben Pastor ha insegnato  Storia e Scienze Sociali presso le università dell’Ohio, dell’Illinois e del Vermont. Oltre al ciclo dedicato al soldato-detective Martin Bora (Lumen, Luna bugiarda, Kaputt Mundi, La canzone del cavaliere, Il morto in piazza, La Venere di Salò, La morte, il diavolo e Martin Bora, Il signore delle cento ossa, Il cielo di stagno e La strada per Itaca (pubblicati in Italia da Hobby & Work e, attualmente, da Sellerio Editore), è autrice dei gialli di ambientazione mitteleuropea I misteri di Praga e La camera dello scirocco, nonché di quattro episodi di una serie ambientata nel IV secolo d.C. Il ladro d’acqua, La voce del fuoco, Le vergini di pietra e La traccia del vento (Frassinelli-Sperling & Kupfer / Hobby & Work), i primi I suoi libri sono pubblicati, oltre che in Italia, negli Stati Uniti, in Canada, Spagna, Germania, Regno Unito, Polonia, Francia, Olanda, Ungheria, Repubblica Ceca, Croazia e Brasile. Nel 2006 ha vinto il premio internazionale “Saturno d’oro” come migliore autrice di romanzi storici, mentre nel 2008 si è aggiudicata il prestigiosissimo “Premio Internacional por la Novela Historica Ciudad de Zaragoza”.
Storia e Scienze Sociali presso le università dell’Ohio, dell’Illinois e del Vermont. Oltre al ciclo dedicato al soldato-detective Martin Bora (Lumen, Luna bugiarda, Kaputt Mundi, La canzone del cavaliere, Il morto in piazza, La Venere di Salò, La morte, il diavolo e Martin Bora, Il signore delle cento ossa, Il cielo di stagno e La strada per Itaca (pubblicati in Italia da Hobby & Work e, attualmente, da Sellerio Editore), è autrice dei gialli di ambientazione mitteleuropea I misteri di Praga e La camera dello scirocco, nonché di quattro episodi di una serie ambientata nel IV secolo d.C. Il ladro d’acqua, La voce del fuoco, Le vergini di pietra e La traccia del vento (Frassinelli-Sperling & Kupfer / Hobby & Work), i primi I suoi libri sono pubblicati, oltre che in Italia, negli Stati Uniti, in Canada, Spagna, Germania, Regno Unito, Polonia, Francia, Olanda, Ungheria, Repubblica Ceca, Croazia e Brasile. Nel 2006 ha vinto il premio internazionale “Saturno d’oro” come migliore autrice di romanzi storici, mentre nel 2008 si è aggiudicata il prestigiosissimo “Premio Internacional por la Novela Historica Ciudad de Zaragoza”.
Ho avuto il piacere di intervistarla nel dicembre del 2013, durante la scrittura del romanzo La strada per Itaca.
****
Tu sei italiana…
…e americana.
…ma allora, da dove viene il nome Ben Pastor?
Ben è short per Verbena, perché il mio nome completo è Maria Verbena Giuditta Fernanda Elvira Carmen (ho avuto i nomi di tutti i miei padrini e madrine; e a uno di loro piaceva l’opera, ma fortunatamente Carmen e non Rigoletto o La traviata); Pastor è il cognome del mio defunto ex-marito. Quindi Ben Pastor è composto da un vero soprannome (il diminutivo di VerBENa) e da un vero cognome, non è uno pseudonimo.
Però scrivi in inglese, e le tue opere in italiano sono tutte traduzioni – come mai?
Ho vissuto quasi tutta la vita – sicuramente la vita lavorativa, e buona parte anche della mia vita fino ad oggi – negli Stati Uniti, e ho sviluppato un affetto particolare per le possibilità della lingua inglese. In inglese ho cominciato a scrivere, e ho poi continuato – è anche la lingua più universale, quindi c’è anche un risvolto pratico, scrivo in una lingua che è più facilmente esportabile.
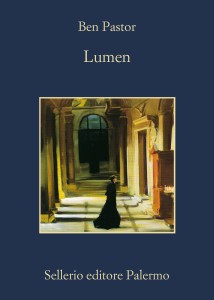 I motivi più profondi però sono altri. Trovo che sia particolarmente utile a chi scrive l’avere a disposizione una lingua che ha alcune caratteristiche in comune con il latino: una sua completezza, una sua stringatezza e un’eleganza formale; una struttura interna della lingua che mi permette di fare cose che non posso replicare con altrettanta felicità in italiano. L’italiano è una lingua bellissima, ma non è maneggevole: al contrario, l’inglese lo è, e credo che in mani attente possa davvero offrire delle possibilità seconde a poche altre.
I motivi più profondi però sono altri. Trovo che sia particolarmente utile a chi scrive l’avere a disposizione una lingua che ha alcune caratteristiche in comune con il latino: una sua completezza, una sua stringatezza e un’eleganza formale; una struttura interna della lingua che mi permette di fare cose che non posso replicare con altrettanta felicità in italiano. L’italiano è una lingua bellissima, ma non è maneggevole: al contrario, l’inglese lo è, e credo che in mani attente possa davvero offrire delle possibilità seconde a poche altre.
Scrivo in italiano soltanto dei racconti, e solo se richiesta direttamente dai miei editori. Mi è già capitato per svariate antologie; di conseguenza, non è che non ne abbia la capacità, ma ho più facilità a scrivere in inglese.
Visto però che per essere letta in Italia devi ricorrere a delle traduzioni, cosa chiedi ai traduttori perché possano superare i limiti a cui hai accennato?
Ho la fortuna, e finora ho avuto la possibilità, di poter rivedere le traduzioni. Nei limiti del possibile, non ci metto di mio altro che quando noto che ci sono delle discrepanze, o altre cose che secondo me non sono espresse esattamente come io le intendevo. Ho meno fortuna in altre lingue che non conosco, e per le quali, quindi, mi devo completamente fidare del traduttore e o della traduttrice – il loro è un lavoro molto difficile, ed essenzialmente ingrato, perché possono essere molto creativi e però, nella loro creatività, devono rispettare il lavoro di un altro. Lo scrittore deve avere la generosità di dare a chi traduce la libertà di ricreare quel mondo, ma questi deve avere a sua volta la generosità di cuore di accettare il fatto che dovendo ricreare un mondo non può prendersi più di tanta libertà.
In questo senso, chiunque scriva deve moltissimo a chi lo traduce, che in realtà deve reinterpretare, ed essere la tua faccia, la tua voce in un’altra lingua.
Uno scrittore come Pavese, che è stato un grandissimo traduttore, ha poi trasferito alcune delle proprie capacità come traduttore nella sua prosa. Quand’ero molto più giovane, ancora prima di sapere che era un grande traduttore, già ravvedevo in lui chi parla correntemente inglese, perché poi, quando si torna all’italiano, si veste un altro abito, cambia leggermente il modo in cui si vede il mondo e lo si costruisce linguisticamente.
Almeno uno degli autori che ami di più, Joseph Conrad – che tra l’altro è un’ispirazione diretta per uno dei tuoi romanzi, Le vergini di pietra – come te non scriveva nella lingua materna. In questo ti identifichi in lui?
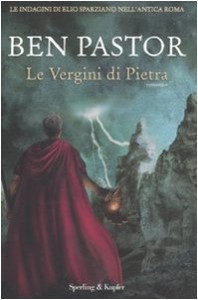 Con tutta umiltà, ovviamente, perché lui è assolutamente un Grande, è stato molto interessante ritrovare nella sua biografia la situazione di chi pensa in una lingua e scrive in un’altra, anche se naturalmente quando scrivo in inglese penso anche in inglese – sarebbe molto complesso fare l’altro passaggio. Mi identifico anche con le difficoltà che a sua volta Conrad ebbe con il suo editor, proprio perché in realtà i due mondi, quello dell’inglese e quello dell’altra lingua – non conosco il polacco ma conosco l’italiano – sono due mondi distinti, discreet si direbbe in inglese, e in realtà non sono pienamente traducibili. Per cui sì, sicuramente mi identifico in Conrad e in generale in chiunque abbia vissuto in una cultura “altra” rispetto alla sua.
Con tutta umiltà, ovviamente, perché lui è assolutamente un Grande, è stato molto interessante ritrovare nella sua biografia la situazione di chi pensa in una lingua e scrive in un’altra, anche se naturalmente quando scrivo in inglese penso anche in inglese – sarebbe molto complesso fare l’altro passaggio. Mi identifico anche con le difficoltà che a sua volta Conrad ebbe con il suo editor, proprio perché in realtà i due mondi, quello dell’inglese e quello dell’altra lingua – non conosco il polacco ma conosco l’italiano – sono due mondi distinti, discreet si direbbe in inglese, e in realtà non sono pienamente traducibili. Per cui sì, sicuramente mi identifico in Conrad e in generale in chiunque abbia vissuto in una cultura “altra” rispetto alla sua.
Tu hai scelto di scrivere in due “generi” allo stesso tempo: il mystery, o più precisamente la detective story, e il romanzo storico. Perché queste due scelte, e soprattutto, perché insieme?
Oramai siamo tutti postmoderni: la mia generazione sicuramente lo è, quindi siamo al di là dell’invenzione, siamo nell’era della rielaborazione, e nessuno di noi, da tempo, crea nulla di nuovo; Shakespeare stesso disse “è già stato tutto scritto”, sono passati quattrocentocinquant’anni, facciamo il conto… è impossibile essere davvero originali.
Detto questo, è possibile, per così dire, mescolare le carte. In realtà il genere onorevole e onorato del romanzo storico, che peraltro ha avuto il suo momento di gloria e ora è meno importante di quanto non sia stato in passato – penso anche solo a Sienkiewicz e ad altri grandi scrittori soprattutto di metà e fine Ottocento – e la detection, che dagli anni Venti, Trenta e Quaranta – non solamente con Agatha Christie e Raymond Chandler – è esplosa come un genere letterario vero e proprio, hanno storie separate.
L’idea di combinarle ovviamente non è mia, però ho trovato che mi fosse congeniale, sia per i miei precedenti accademici (perché ho insegnato storia – la storia antica ma anche la storia contemporanea del ventesimo secolo), sia per un interesse forse non proprio archeologico ma almeno antiquario: perché tanto l’antiquario quanto l’archeologo cercano di scoprire cosa è sepolto, e così fa anche l’investigatore.
Ho solo dovuto trasferire questo mio interesse legato alla cultura antiquaria del passato, alla detection, con cui avevo meno familiarità; e cercare di combinare queste cose in un modo che mi fosse utile. Ora, questa operazione presenta dei rischi, perché i lettori di gialli sono molto attenti e generalmente molto colti nel genere e spesso anche fuori del genere; e così anche i lettori di storia e di romanzi storici. Quindi si aggiunge anche la difficoltà di scrivere per un doppio pubblico che è molto ben preparato, e non ci si può permettere di sbagliare più di tanto.
Per non sbagliare, quanta ricerca fai, e come ti prepari? Nei tuoi romanzi ci sono ricostruzioni dettagliate dell’Antico Egitto e della Roma Imperiale, di avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, descrizioni di città come Praga con dettagli architettonici, culturali, dell’abbigliamento… quanto materiale raccogli, e vai anche sul posto a documentarti?
Per quanto è possibile, vado certamente sul posto. Questo sembra più difficile per l’antichità, ma anche l’antichità è un luogo: oramai il luogo dell’antichità è deputato ai buoni musei, ai buoni cataloghi d’arte, il lavoro è ovvio.
Stranamente il lavoro è più complesso quando ha a che fare con il ventesimo secolo, perché l’antichità oramai è consegnata a se stessa, e nessuno di noi ha più difficoltà ad accettare le realtà, anche politiche, del Dominato (come si diceva una volta del tardo Impero), che sono legate alle nazionalità, all’ascesa del Cristianesimo, alla fine del paganesimo. Ormai questi contesti non sono più in discussione tra gli studiosi, mentre il Ventesimo Secolo e la Seconda Guerra Mondiale ancora sì. Quindi si tratta non solo di fare ricerca, ma di fare ricerca onorando la verità per quanto si può; e d’altra parte, permettendoci quello che sempre dovremmo fare, sentirci liberi nei confronti dell’interpretazione storica, altrimenti davvero si seppellisce la natura della Storia stessa – negazionismo mai, revisionismo sempre; sempre si deve rivedere la Storia. L’hanno riveduta i sovietici quando hanno scritto della “grande guerra patriottica”, la rivediamo noi man mano che scopriamo altri elementi della nostra storia recente.
Per quanto riguarda invece l’intreccio narrativo, quanto progetti in anticipo e collaudi l’intreccio poliziesco in modo che tutti i dettagli, anche quelli che in apparenza sembravano insignificanti come uno sguardo o un’osservazione e si rivelano poi indizi importanti, alla fine stiano in piedi? Ti fai aiutare a verificare o correggere?
Hitchcock strikes again – perché Hitchcock è il grande maestro del dettaglio che va a lanciare un’ombra lunghissima che fa poi combaciare tutto, non solo nel giallo, ma nella narrativa in generale. Credo che in un romanzo le cose dovrebbero tornare in toto, che si tratti di una detective story o meno. Io cerco di fare farina del mio sacco, perché c’è molto nel mondo e, nonostante tutto sia stato scritto, non tutto è stato detto, quindi saper scrivere in un genere è nello stesso tempo raccontare cose che si imparano ogni giorno. Proprio oggi, ad esempio, ho appreso un dettaglio prezioso che userò nel prossimo romanzo.
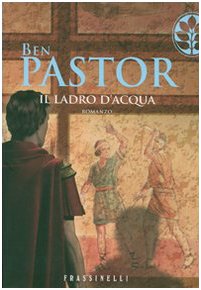 Tuttavia non preparo mai una scaletta, il che è una cosa che molti, incluso il mio editor storico, trovano assolutamente fuori dalle regole, perché sembra che ci sia una confusione di fondo, e in effetti è così. C’è una specie di “brodo primordiale”, che non vuol dire che io non abbia delle idee, ma che queste non sono ancora coese, ci sono solo delle possibilità. Credo che nella vita reale, come nella vita di un investigatore, esistano innumerevoli possibilità, che poi vanno vagliate: e io procedo più o meno come fa l’investigatore, esplorandole tutte, non negandone alcuna; e alla fine scoprendo anch’io quello che scopre lui, in modo molto organico.
Tuttavia non preparo mai una scaletta, il che è una cosa che molti, incluso il mio editor storico, trovano assolutamente fuori dalle regole, perché sembra che ci sia una confusione di fondo, e in effetti è così. C’è una specie di “brodo primordiale”, che non vuol dire che io non abbia delle idee, ma che queste non sono ancora coese, ci sono solo delle possibilità. Credo che nella vita reale, come nella vita di un investigatore, esistano innumerevoli possibilità, che poi vanno vagliate: e io procedo più o meno come fa l’investigatore, esplorandole tutte, non negandone alcuna; e alla fine scoprendo anch’io quello che scopre lui, in modo molto organico.
In quasi tutte le tue opere, tranne forse nel ciclo di Elio Sparziano, affianchi al tuo Holmes un Watson, che cambia di volta in volta nei romanzi di Martin Bora mentre invece la coppia è fissa nei racconti di Praga, nei quali, tra l’altro, Conan Doyle è citato esplicitamente. Che funzione hanno queste controparti?
Credo che quando si scrive si debba dare sempre importanza al dialogo. Il dialogo deve sempre far avanzare la storia, nessun dialogo dev’essere senza necessità, quindi a qualche livello deve servire: o a rilevare peculiarità dei protagonisti, che non sono altrimenti specificate, o – ancora più importante – a rivelare elementi del giallo che poi si svilupperanno. E se i dialoghi sono essenziali, ça va sans dire, devono esserci degli interlocutori. L’idea è di un Watson come sounding board, che può essere una persona meno o più preparata dell’investigatore, perché molto spesso, in Martin Bora e soprattutto nel ciclo di Praga, gli investigatori non sono allo stesso livello, ma può essere utile anche questo; del resto anche in Conan Doyle è Watson che scrive, e Watson sta a Sherlock Holmes come Platone sta a Socrate.
L’importante, però, è di avere un dialogante, non tanto qualcuno che aiuti a scoprire o a svelare il mistero, o addirittura a fare a pistolettate o a pugni.
Quindi non un sidekick, come Robin per Batman?
No: per quanto io sia cresciuta con Batman e Robin, e non abbia niente contro i sidekicks, credo che sia molto più interessante avere un gioco delle menti – non necessariamente intellettuale, ma anche solo di conversazione. L’importante è avere qualcun altro con cui parlare, e avrai notato che quando non hanno nessuno con cui dialogare, i miei personaggi scrivono un diario…
Infatti, questa sarebbe stata la mia domanda successiva: al di là del dialogo, tutti i tuoi personaggi scrivono molto – questo ti serve come strumento narrativo, oppure è un modo per conferire loro la tua voce?
Sì, sono grafomani… ma non sono quasi mai io a parlare, non ho mai cercato di entrare nei miei romanzi perché questi sono altra cosa da me. I loro scritti sono in realtà quello che i protagonisti stessi possono dire e io non potrei, contengono dei loro giudizi sul loro mondo e sugli altri; giudizi che io non mi permetterei mai di dare mentre loro, come uomini e donne del loro tempo, possono farlo. C’è un ulteriore livello di libertà, è il momento della riflessione – si è parlato dell’importanza che hanno avuto i diari e i resoconti che i nostri nonni tenevano come giovani uomini, e che erano legati proprio al periodo in cui si verbalizzava per iscritto quello che si pensava: non si mandavano messaggi ma si scriveva in maniera elegante (per quanto si poteva farlo a tredici, quattordici, vent’anni) la propria esperienza del mondo.
I miei personaggi sono dei giovani tra i ventitré e i trent’anni: uomini fatti, per l’epoca, ma sicuramente molto giovani per noi contemporanei, e capaci, sia pure nelle loro esuberanze giovanili, di articolare i propri pensieri riguardo a se stessi e al mondo.
Devo dire che amo molto anche i romanzi epistolari: oggi, per esempio, ben pochi si rendono conto che anche Dracula è un romanzo epistolare!
Come si vede proprio dalle riflessioni che mettono per iscritto, i tuoi personaggi evolvono da un romanzo all’altro; cambia la loro consapevolezza degli eventi e di se stessi. Quanto questo fa parte di un tuo disegno, o quanto hanno fatto, per così dire, loro di propria iniziativa?
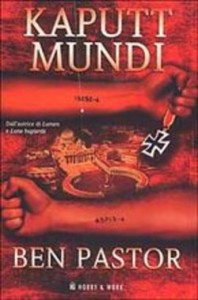 I personaggi, come ben si sa, sono i nostri figli: puoi tutt’al più portarli al mondo, ma il resto poi lo fanno loro nonostante i nostri peggiori o migliori sforzi. In realtà questa idea c’era comunque fin dall’inizio, perché ho sempre trovato un po’ velleitaria la concezione del personaggio che in maniera sempre uguale si ritrova a confrontare una varietà di casi o incidenti, ma senza che il suo mondo cambi mai; innanzitutto perché life happens, la vita ci succede intorno. Come nella mia vita ogni episodio è stato legato a circostanze anche distraenti di ogni tipo, soprattutto per personaggi come i miei, che sono tutti in un modo o nell’altro nell’esercito, ci sono molte cose che li distraggono; e credo che sia importante farli vedere, a seconda del periodo, reagire a ciò che accade intorno a loro anche cronologicamente. Ecco perché, ad esempio, seguiamo Martin Bora dai ventitré anni fino alla trentina: perché erano anni davvero formativi, e per un uomo degli anni Trenta e Quaranta era il momento in cui si passava davvero alla piena età adulta.
I personaggi, come ben si sa, sono i nostri figli: puoi tutt’al più portarli al mondo, ma il resto poi lo fanno loro nonostante i nostri peggiori o migliori sforzi. In realtà questa idea c’era comunque fin dall’inizio, perché ho sempre trovato un po’ velleitaria la concezione del personaggio che in maniera sempre uguale si ritrova a confrontare una varietà di casi o incidenti, ma senza che il suo mondo cambi mai; innanzitutto perché life happens, la vita ci succede intorno. Come nella mia vita ogni episodio è stato legato a circostanze anche distraenti di ogni tipo, soprattutto per personaggi come i miei, che sono tutti in un modo o nell’altro nell’esercito, ci sono molte cose che li distraggono; e credo che sia importante farli vedere, a seconda del periodo, reagire a ciò che accade intorno a loro anche cronologicamente. Ecco perché, ad esempio, seguiamo Martin Bora dai ventitré anni fino alla trentina: perché erano anni davvero formativi, e per un uomo degli anni Trenta e Quaranta era il momento in cui si passava davvero alla piena età adulta.
Però molti dei tuoi romanzi non sono stati scritti né pubblicati secondo l’ordine della cronologia interna del personaggio. In proposito, segui una traccia già definita, o qualcosa può ancora cambiare? Per esempio, sapevi che Martin non sarebbe stato tra coloro che furono giustiziati per il fallito attentato a Hitler?
No. Quand’ero molto più giovane uccidevo molto più facilmente i miei protagonisti, ma adesso che lo sono un po’ meno, faccio più attenzione.
La biografia di Elio Sparziano l’ho tutta abbastanza chiara, mentre per quella di Martin Bora ho una falsariga di massima. L’unica cosa che ho progettato è un piccolo file che ho da parte e che contiene la sua cronologia dalla nascita, compresi i suoi studi (che avranno importanza nel prossimo romanzo), e un altro con la sua genealogia.
Io non sono affatto una fan della genealogia, ma per un personaggio della cultura e dello strato sociale di Martin Bora è importante sapere chi sono li maggior sui, chi sono i suoi genitori, i suoi nonni e i suoi avi, perché questi lo rendono quello che è.
Avendo preparato tutta questa costruzione, il resto è abbastanza ampio e libero. So più o meno cosa succederà fino al 1945; dopodiché non mi pronuncio.
Non ci hai ancora spiegato il significato del “sette” profetizzato da Remedios in La canzone del Cavaliere…
…probabilmente perché non ne sono sicura io stessa; ma lo scoprirò e sarete i primi a saperlo.
Passando alle caratteristiche dei tuoi personaggi, c’è un motivo per cui, indipendentemente dalle epoche storiche, sono tutti ufficiali di cavalleria mitteleuropei?
Sono una feticista… è una cosa stranissima, probabilmente ho cavalcato tre volte in vita mia, ma ho quest’immagine che non riesco in realtà a riportare a nulla della mia esperienza concreta. Ci sono degli archetipi che credo non siano autogenerati, e nascono da una fascinazione: io sono una patita delle uniformi in generale, e riservo una particolare attenzione ad alcune uniformi specifiche (quelle tardo romane sicuramente, ma anche altre di origine ottocentesca e novecentesca). Siccome la mia fascinazione “feticistica” è legata alla forma (non tanto all’oggetto in sé e alle sue componenti materiali: cuoio, stoffa o acciaio), tutte le cose che hanno quella forma mi attraggono, e quindi, più di ogni altri, certi periodi storici e certi tipi di uniformi.
Quanto alla scelta del grado, altri hanno scelto il personaggio di un soldato semplice, come il caporale Asch che poi diventa il tenente Asch, oppure Horatio Hornblower, che è il grande archetipo di tutti i promossi nei ranghi; ma la mia scelta di farne degli ufficiali, ancorché Elio sia di origine proletaria, e gli altri due della piccola e media aristocrazia della Mitteleuropa, non è tanto di rango sociale quanto legata soprattutto al fatto che devono aver la possibilità di interagire con personaggi stuzzicanti e importanti che mi interessano, nello spionaggio o nelle corti europee, e questo non sarebbe possibile a un livello che non fosse almeno quello di rango degli ufficiali. Un po’ come i moschettieri, che in fin dei conti sono ufficiali molto eterodossi, ma sono ben introdotti a corte.
Nei tuoi romanzi ci sono anche descrizioni molto precise di manovre militari proprio di cavalleria, come l’assalto ai ribelli, o azioni di controllo della folla, o di pattugliamento – quelle le conoscevi o hai dovuto documentarti?
Ahimè, ho dovuto ricorrere ai manuali: manuali di cavalleria e manuali di tattica, non di strategia ma di tattica sicuramente, a cominciare dallo Strategikon di Maurizio Imperatore del sesto secolo, che è il grande manuale della tattica di cavalleria del tardo impero. Ci sono dei testi meravigliosi e io ho anche la fortuna di avere buoni conoscenti tra i militari di carriera, che naturalmente mi bacchetterebbero in maniera rapida se facessi degli errori, e che mi forniscono anche informazioni che io, non avendo neanche fatto il militare a Cuneo, non potrei conoscere.
Al di fuori dei tuoi protagonisti e dei loro occasionali assistenti o controparti, nei tuoi romanzi i maschi non fanno quasi mai una bella figura, sempre ossessionati dal sesso o dal potere. Al contrario, le tue donne sono sempre molto particolari; sono tutte donne che hanno un potere reale anche se non sempre risulta subito chiaro, e soprattutto non si concedono mai completamente: che siano Anubina o Benedikta o Polyxena, per non parlare di Remedios che ne è l’archetipo, concedono volentieri il loro corpo ma restano sempre distanti. Come mai?
 Ti rigrazio della domanda, perché questa è un aspetto della mia narrativa di cui non si è accorto quasi nessuno, e la domanda che invece mi viene sempre fatta è perché io parli solo di uomini e le donne quasi non esistano. In realtà sono donne che lavorano dietro le quinte, come spesso una donna è costretta a fare.
Ti rigrazio della domanda, perché questa è un aspetto della mia narrativa di cui non si è accorto quasi nessuno, e la domanda che invece mi viene sempre fatta è perché io parli solo di uomini e le donne quasi non esistano. In realtà sono donne che lavorano dietro le quinte, come spesso una donna è costretta a fare.
C’è effettivamente un archetipo e un prototipo: non una dea, ma una ninfa, Calipso, “Calipso la velata”. Io credo che l’idea della “donna velata”, che è poi la grande intuizione dei vittoriani e degli eduardiani, la donna che non si vede completamente – ci sono molti modi di farlo, dal far vedere solo la caviglia o anche soltanto lo spazio tra il guanto e la manica, queste piccole rivelazioni che tradizionalmente, e credo tuttora, per un certo tipo di maschio possono essere il locus del fascino – sia un’antichissima lezione anche per la sessualità contemporanea,
Ma si può essere velate in altro modo, e in realtà io mi permetto di dire che credo che raramente le donne si diano davvero, e che gli uomini si diano molto più prontamente e generosamente da una parte, e ingenuamente dall’altra, di quanto non facciano le donne.
La donna si trattiene sempre; è una specie di riserva mentale. Anche quando proclama apertamente il suo affetto e il suo amore, ed è sincera, c’è una parte di sé che per motivi quasi territoriali tende a custodire gelosamente, come ambito proprio. Non credo sia una virtù, credo sia soltanto un modo di essere nel mondo che è tipico delle donne e non degli uomini.
Non ho un’enorme esperienza in proposito, però ho notato, anche fra le persone che conosco, che nel bene e nel male l’uomo è più schietto anche nella cattiveria profonda; una donna è molto più velata e molto più attenta, in parte per ragioni storiche ma in parte, credo, anche per una certa fisiologia di secondo livello della verginità: cioè, posso dare quello ma questo no. Ricordo la storia che mi raccontava il mio defunto marito, che aveva diversi anni più di me ed era andato come giovane marinaio in Corea a diciott’anni, quindi uscito dalla scuola religiosa e gettato non solo nella guerra ma anche nel mondo dei maschi. I suoi commilitoni lo portarono in un bordello giapponese in cui incontrò la sua prima donna: la quale però non baciava i clienti, perché i baci erano solo per il vero amante.
Io credo che sia davvero questo il prototipo di Calipso, che le donne della mia narrativa in qualche modo incarnano; inoltre ho sempre trovato affascinante l’innamorato che non ha grande fortuna, mentre lo “sciupafemmine” non mi piace molto: troppo scontato e banale.
Ho l’impressione che i tuoi protagonisti maschili, pur essendo chiaramente eterosessuali, non siano solo maschi alfa, e abbiano o acquistino una crescente consapevolezza di un elemento femminile nel proprio carattere.
 Anche questo è intenzionale e pianificato, e anche questo è regolarmente non colto. Cioè l’idea un po’ junghiana che tanto più il carattere esibito è maschile e femminile, tanto più è sviluppato l’animus, l’elemento per così dire maschile nella donna, e l’anima, l’elemento femminile, nell’uomo; da cui l’idea che il maschio che è sicuro di se stesso può essere tenero, mentre è sempre il maschio insicuro che tende ad aver difficoltà con la propria tenerezza, proprio per quella schiettezza di cui si parlava prima.
Anche questo è intenzionale e pianificato, e anche questo è regolarmente non colto. Cioè l’idea un po’ junghiana che tanto più il carattere esibito è maschile e femminile, tanto più è sviluppato l’animus, l’elemento per così dire maschile nella donna, e l’anima, l’elemento femminile, nell’uomo; da cui l’idea che il maschio che è sicuro di se stesso può essere tenero, mentre è sempre il maschio insicuro che tende ad aver difficoltà con la propria tenerezza, proprio per quella schiettezza di cui si parlava prima.
In questo senso, sì, anche i maschi delle mie storie sono a loro volta velati, perché a loro volta non si concedono mai completamente; hanno un piccolo mondo interno, legato alle proprie preoccupazioni, ai propri diari, che resta molto intimo, molto privato. È proprio l’elemento anima, e non solo quello, che permette loro di avere una certa “grazia”, intesa nel senso religioso: una grazia che è il dono di riconoscere l’importanza degli altri, ma anche quello di esercitare una specie di riservatezza nella propria interiorità più autentica, una propensione che, a ben vedere, non è affatto da maschio alfa.
Allargando il discorso, vorrei spezzare una lancia a favore degli uomini: sono una femminista di terza generazione e me lo posso permettere. In realtà, ed è una cosa davvero interessante, per molto tempo (quasi trent’anni) nei gender studies abbiamo affettato la torta con l’accetta, e abbiamo detto che essere donne è bello, che essere maschio è retrivo etc. etc. In realtà, più vado avanti con gli anni e più mi rendo conto che gli uomini sono sicuramente più ingenui e più diretti delle donne: sia pure con molte eccezioni (abbiamo fin troppi politici che lo dimostrano), in linea generale è così.
Ma la loro generosità, ingenuità e schiettezza non sono riassumibili nella categoria della semplicità. Molto spesso ci si diceva da ragazze, “sono così semplici”, ma gli uomini non sono semplici affatto: hanno dei livelli che sono salvaguardati attentamente quanto i nostri, soltanto in maniera diversa. Siamo come due case che si fronteggiano e hanno le finestre aperte, ma mai del tutto, come pure le porte. In realtà gli uomini sono complessi quanto le donne, ma ne sono scarsamente consapevoli, il che è un limite che trovo adorabile. Hanno i loro valori e, per esempio, sono pronti a morire in guerra: uomini di squisita intelligenza e altissima preparazione sono andati a farsi ammazzare nelle trincee. Io non credo che molte donne andrebbero a morire in guerra: perché gli uomini lo fanno? Perché c’è una specie di generosità di fondo, belluina se si vuole, che travalica anche la loro complessità. Le donne si autotutelano e si conservano; gli uomini sono complessi e si donano, ed è questo che apprezzo in loro.
E adesso che cosa hai in programma per i tuoi personaggi?
Elio Sparziano ormai ha fatto esperienza dei quattro elementi, sicché dovrebbe arrivare alla quintessenza, cioè al quinto elemento: vedremo cosa accadrà. Da quel che ne so, adesso dovrebbe trovarsi in Siria o Palestina, probabilmente a cercare un tesoro – di cui si è parlato in un romanzo precedente – che forse è più nella sua mente che nella realtà…
A differenza di Martin Bora, Elio vive un’avventura dopo l’altra; tutti i suoi romazi si concentrano in un arco temporale di un paio d’anni…
Sì, quest’uomo ha la velocità del vento. Entro le regole romane, senza dubbio, ma con un’energia incredibile.
 Quanto agli altri miei personaggi,nel prossimo romanzo di Martin Bora il mio eroe si ritroverà a Creta nel 1941, dopo la sanguinosissima invasione aviotrasportata dell’isola, alle prese con un intricato caso d’omicidio che potrebbe avere ripercussioni internazionali. Accanto a questa indagine, Martin dovrà rivivere alcuni episodi della sua infanzia, insospettabilmente legati al misterioso caso di assassinio che è chiamato a risolvere.
Quanto agli altri miei personaggi,nel prossimo romanzo di Martin Bora il mio eroe si ritroverà a Creta nel 1941, dopo la sanguinosissima invasione aviotrasportata dell’isola, alle prese con un intricato caso d’omicidio che potrebbe avere ripercussioni internazionali. Accanto a questa indagine, Martin dovrà rivivere alcuni episodi della sua infanzia, insospettabilmente legati al misterioso caso di assassinio che è chiamato a risolvere.
Per quanto riguarda il ciclo di Praga, mi sto confrontando col fatto che è molto difficile raccontare la Mitteleuropa quando la guerra è già scoppiata (alludo ovviamente al primo conflitto mondiale). Mi chiedo se fare un prequel, o continuare a cercare di salvare qualcosa di un mondo destinato all’eclissi totale (almeno fino alla caduta del Muro di Berlino), oppure tenere questi personaggi in salamoia: come anche i nostri cervelli, forse, saranno tenuti in salamoia, visto che il nostro immaginario di essere umani nati e maturati nel Novecento sembra destinato a spegnersi con noi.
 (originariamente pubblicato nel volume
(originariamente pubblicato nel volume
Dietro le quinte del noir : gli addetti ai lavori si raccontano
a cura di Alessandra Calanchi
Galaad Edizioni, Giulianova, 2014)
