In occasione della presentazione del volume di Veronica Pravadelli Le donne del cinema. Dive, registe, spettatrici presso la Biblioteca “Renzo Renzi” giovedì 16 aprile, ho avuto la possibilità di porre all’autrice qualche domanda sugli argomenti affrontati nel testo.
La prima parte del volume è dedicata al ruolo delle spettatrici: quanto il cinema ha cambiato e ancora cambia l’immagine che la donna ha di se stessa, e quanto invece sono ruoli che le donne assumono nella società a cambiare l’immagine che il cinema dà di esse?
A mio giudizio, per capire l’efficacia del cinema, soprattutto in relazione alle spettatrici dei primi decenni, è fondamentale pensare a esso come un dispositivo – basato su immagini di grandi dimensioni 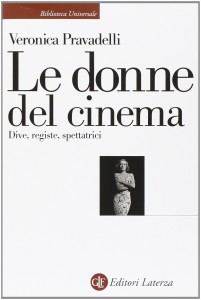 proiettate a un pubblico potenzialmente quasi infinito – in grado di trasformare ogni elemento di partenza, che può essere quello che noi in generale chiamiamo realtà, ma anche solo un’immagine, una storia, qualunque cosa.
proiettate a un pubblico potenzialmente quasi infinito – in grado di trasformare ogni elemento di partenza, che può essere quello che noi in generale chiamiamo realtà, ma anche solo un’immagine, una storia, qualunque cosa.
Credo che sia questa capacità di trasformazione che ha reso il cinema così importante e così influente: perché attraverso la macchina da presa gli elementi di partenza vengono resi molto più forti, intensi ed efficaci di quanto potrebbero essere in un altro contesto. E credo anche che questo sia stato molto più importante per le spettatrici di quanto non lo sia stato per gli spettatori; perché proprio il momento in cui il cinema nasce – a cavallo tra Otto e Novecento – è anche il momento in cui per la prima volta le donne acquisiscono una nuova dimensione pubblica. La modernità infatti cambia la vita delle donne molto più di quanto non cambi quella degli uomini. Poiché queste trasformazioni avvengono in concomitanza il nesso cinema/modernità/nuova donna rende le potenzialità del cinema più coinvolgenti per le spettatrici. Certo, il cinema ha grande potere anche sugli spettatori maschi, ma basandomi su studi precedenti e sulla mia indagine ritengo di poter affermare che ha agito con forza e influenza maggiore, in senso positivo, sulle donne.
Questa efficacia continua anche in seguito in altre forme. Per esempio, nei primi decenni del cinema classico, negli Stati Uniti alcune ricerche svelano che le donne sono responsabili della scelta dei film, nel senso che in una coppia è la donna più che l’uomo a scegliere cosa andare a vedere. In quegli anni l’industria cinematografica cerca di sfruttare questa dinamica e per assecondare i desideri della spettatrice investe grandi capitali su film che narrano le traiettorie della New Woman. In generale, ritengo che il rapporto speciale tra cinema e donne continui oltre il periodo dei primi decenni del Novecento, anche se non sono in grado di affermare che si possa estendere genericamente alla storia del cinema.
Tutto il volume è permeato dalla permanenza del binomio femminilità-modernità nella cultura cinematografica e visuale del Novecento. Secondo Lei, questo è ancora vero in questo inizio di nuovo millennio anche dopo la “fine della modernità”?
È vero, questo può essere considerato il filo conduttore del volume. Credo che il concetto di modernità resti del tutto attuale, e possa essere ancora utilizzato. Naturalmente dobbiamo distinguere tra la modernità a cavallo tra Otto e Novecento, che coincide con la grande urbanizzazione, e che è associata a quel momento storico particolare, e un concetto più ampio di modernità, da vedere in opposizione al concetto di tradizione, una sorta di riattualizzazione della “querelle des anciens et des modernes”. Pensiamo per esempio a Brigitte Bardot. Il successo della sua immagine divistica fu dovuto proprio al fatto di incarnare uno stile di vita moderno, di incarnare i desideri della nuova generazione dei giovani francesi, in opposizione alle dive del cinema francese del tempo legate a modi di essere tradizionali e conservatori. In questo senso il concetto di modernità può essere facilmente evocato per parlare di molto cinema delle donne contemporaneo.
L’emancipazione femminile ha una geografia mobile, giacché il processo di emancipazione non è un qualcosa di concluso, definito, ma è un processo costante e ancora in essere in Paesi che si trovano a livelli diversi del loro cosiddetto “sviluppo”, o per “gruppi” particolari di donne in Paesi che definiamo “sviluppati”. L’immaginario del cinema delle donne contemporaneo racconta molto bene questa condizione, come si vede per esempio nel cinema dei Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente che affronto nell’ultima parte del libro. Ma questo è vero per la gran parte del cinema a regia femminile prodotto in paesi non occidentali. La tendenza è di raccontare la ricerca da parte del personaggio femminile di una propria emancipazione rispetto alle tradizioni che in qualche modo limitano la sua libertà. Credo pertanto che, debitamente rivista, la questione della modernità rimanga del tutto attuale, nell’ambito della geografia mobile di cui parlavo e di contesti nazionali e geografici diversi. Trovo in realtà molto più interessanti queste cinematografie cosiddette emergenti rispetto al cinema europeo che racconta storie di coppie o famiglie in crisi, o storie di adulterio.
La sezione dedicata alle dive, contiene interessanti riflessioni sull’immagine divistica come “polisemia strutturata”, e sulla distinzione tra attrici che si sono proposte come “superfemmina” e altre come “superdonna”. Può illustrarci questi concetti?
Queste sono definizioni che riprendo da Molly Haskell, che nel 1974 ha scritto un libro (From Reverence to Rape. The Treatment of Women in the Movies) che affronta in modo articolato e intelligente la trasformazione dell’immagine femminile, soprattutto nel cinema americano. Molly Haskell fa questa distinzione tra “superdonna” e “superfemmina”. Si tratta sempre di dive “forti”: la “ superfemmina” è una diva che interpreta ruoli di donna forte, ma rimane nell’ambito domestico, e ha quindi una femminilità eccessiva e quasi demoniaca che esercita in modo negativo, come è il caso di molti personaggi di Bette Davis o anche di Gene Tierney; mentre la “superdonna” ha un connotato che potremmo definire più positivo, è una donna che riesce a muoversi al di fuori dell’ambiente domestico, la sua forza si esplica anche in un contesto pubblico e per questo assume a volte dei tratti mascolini – uno degli esempi classici è quello di Joan Crawford in Johnny Guitar.
Questa distinzione a me sembra estremamente interessante. Per me è stata utile perché mi ha aiutato a formulare una tesi di più ampia portata sul divismo, una tesi che va in una direzione opposta rispetto alle teorie femministe. A mio avviso il divismo femminile è di per sé un fenomeno che ha dato grande forza al soggetto femminile: la diva è in quanto tale una donna attiva e importante, perché è al centro dell’immagine e del racconto, ed è talmente forte che anche nel caso in cui sia sottoposta a un certo grado di erotizzazione – cosa che in effetti accade quasi sempre – non vuol dire che sia sottomessa e controllata, secondo la famosa ipotesi di Laura Mulvey, dallo sguardo o dal desiderio maschile (personaggio e regista). Ritengo che sia invece presente un certo livello di attività e di emancipazione, dato proprio dall’importanza che le donne hanno acquisito attraverso il divismo; e che proprio il dispositivo del cinema, con questa sua intensità e questa sua forza, è stato in grado di trasmettere questa forza anche alle spettatrici.
Nell’elaborazione di questa tesi mi è stato utile il libro di Heide Schlüpmann Unheimlichkeit des Blicks: Das Drama des Frühen deutschen Kinos, uno studio sul cinema tedesco degli anni dieci con elementi che, debitamente rielaborati, possono valere anche in seguito. Al contrario di quello che la Feminist Film Theory ha sostenuto per anni, che le dive sono sostanzialmente delle immagini femminili sessualizzate e quindi controllate dal desiderio maschile, io sono convinta che questa sia solo metà della storia: l’altra metà invece è rappresentata da questa forza intrinseca.
Questo ci porta alla questione della “polisemia strutturata” a cui abbiamo accennato, che è un concetto fondamentale del libro di Richard Dyer, Star. Penso che l’immagine femminile comprenda elementi femminili e maschili, passivi e attivi, e che tutto sommato le immagini di donna – penso soprattutto a quelle hollywoodiane, perché è un cinema che costituisce un punto di riferimento imprescindibile e il suo funzionamento non è mai scomparso del tutto –, le immagini delle dive siano salvo rari casi molto più complesse e più contraddittorie di quelle maschili e contengano una carica anche sovversiva che molti non hanno saputo riconoscere. Del resto, se si leggono le cronache dell’industria ci si accorge di quanto in alcuni decenni le attrici siano fondamentali: non sono la regista del film ma certo hanno un potere di controllo superiore a quello del regista stesso.
La mia intenzione in questo libro è stata anche quella di cercare di sfatare certi cliché e di vedere le cose come contraddittorie: non completamente positive o negative ma come fenomeni che hanno delle dinamiche complesse, in cui per la spettatrice o per la studiosa c’è la possibilità di trovare elementi di emancipazione, magari non intenzionali.
Lei ricorda come nel cinema delle origini ci siano state donne registe e produttrici, in ruoli sostanzialmente alla pari con i loro omologhi maschili, ma dagli anni 20 in poi queste sono sostanzialmente sparite, tranne rarissimi esempi; e anche oggi le donne autrici si muovono soprattutto in ambiti “di nicchia”, e sono praticamente assenti dal cinema mainstream. Secondo Lei, a cosa si deve la permanenza di questo “soffitto di vetro”?
Credo che sia un dato di fatto incontrovertibile che l’industria è reticente ad affidare un grande budget a una donna. Ma io sospetto che in realtà la preferenza delle donne a lavorare nel cinema narrativo indipendente o in quello documentario sia anche frutto di una scelta, che le donne in fondo preferiscano muoversi nell’ambito di produzioni indipendenti in cui la regista, che spesso è anche la sceneggiatrice, ha il controllo di una produzione che è una piccola macchina; e che ci sia ancora difficoltà da parte delle donne a gestire grandi macchine (anche da parte di molti uomini, del resto – il cinema è pieno di registi che non hanno mai gestito una grande macchina produttiva, è molto difficile). Penso che da un lato questo dipenda da una mancanza di coraggio nel misurarsi con questo tipo di produzioni, perché storicamente le donne sono sempre state assenti, e nessuno le ha mai aiutate; d’altra parte credo che se questi spazi non se li conquistano da sole difficilmente verranno loro concessi.
Forse questa è un’interpretazione che deriva dal cinema d’avanguardia, ma che mi sento di estendere un po’ anche ad altri tipi di cinema “non dominanti”. La marginalità è sempre stata così caratteristica delle donne in tutti gli ambiti, che tutto sommato continua e si mantiene, anche se a livelli inferiori rispetto a una volta, in molti contesti, come la produzione cinematografica. Penso che non sia semplicemente l’industria a non volere le donne nel ruolo di regista di grandi macchine produttive, ma che esse stesse si trovino più a proprio agio in produzioni piccole, anche per inesperienza e per mancanza di esempi: ma spero sempre che una come Bigelow, caso oggi più unico che raro, possa servire come modello. Così come le spettatrici si sono fatte influenzare dalle storie che hanno visto, anche le registe potrebbero in qualche modo imitare modelli precedenti.
Veronica Pravadelli
Le donne del cinema. Dive, registe, spettatrici
Biblioteca Universale Laterza, Roma-Bari 2014
